In libreria: Sacerdoti e briganti tra Romagna e Toscana
di Massimo Ragazzini -
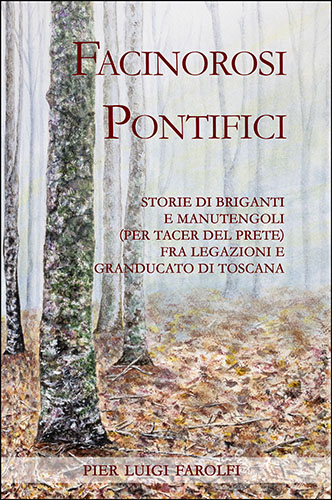 Cultore di storia locale originario di Portico di Romagna, Pier Luigi Farolfi ha iniziato oltre vent’anni fa a interessarsi della storia del brigantaggio romagnolo nel decennio successivo alla prima guerra d’indipendenza (1848-49). Le sue ricerche si sono svolte presso gli Archivi di Stato della Toscana, prevalentemente in quello di Firenze, e presso gli Archivi romagnoli, fra i quali l’Archivio del Comune di Modigliana e quello della Diocesi di Faenza-Modigliana.
Cultore di storia locale originario di Portico di Romagna, Pier Luigi Farolfi ha iniziato oltre vent’anni fa a interessarsi della storia del brigantaggio romagnolo nel decennio successivo alla prima guerra d’indipendenza (1848-49). Le sue ricerche si sono svolte presso gli Archivi di Stato della Toscana, prevalentemente in quello di Firenze, e presso gli Archivi romagnoli, fra i quali l’Archivio del Comune di Modigliana e quello della Diocesi di Faenza-Modigliana.
Il titolo del libro riprende la definizione di “facinorosi pontifici” coniata dai funzionari statali toscani per identificare i banditi provenienti dallo Stato della Chiesa.
L’originalità di questo ponderoso volume (448 pagine stampate con caratteri piccoli) risiede nella profondità e nell’accuratezza della ricerca delle fonti e nella “prospettiva toscana” dello studio, poiché tipicamente i libri sul Passatore e sugli altri banditi romagnoli sono basati in prevalenza su fonti pontificie. L’Autore ha portato alla luce materiale inedito, tra cui molti documenti delle autorità e delle forze dell’ordine del Granducato, in particolare della sottoprefettura di Rocca San Casciano, e atti dei procedimenti penali a carico dei briganti e dei loro fiancheggiatori. Accadeva infatti con frequenza che le bande armate del Passatore, di Lazzarino, di Lisagna sconfinassero dalla Romagna pontificia nella Romagna toscana, sia per trovarvi rifugio e accoglienza, a volte forzata e a volte compiacente, sia per compiere anche in queste terre assalti e ruberie.
Le vicende narrate si svolgono quindi prevalentemente nella Romagna toscana, la parte del Granducato compresa nel versante padano dell’Appennino tosco-romagnolo, detta comunemente anche “lo Stato di sopra” per la morfologia alpestre del territorio, e in parte anche nella Romagna pontificia, ovvero le Legazioni di Forlì, Ravenna, Bologna e Ferrara, dette anche “lo Stato di sotto” per le caratteristiche pianeggianti.
Il personaggio principale della ricerca è un sacerdote del quale finora poco è stato scritto, don Pietro Valgimigli, soprannominato don Stiffelone, arciprete della parrocchia di San Valentino, fra Tredozio e Modigliana. In un rapporto ‘riservatissimo’ del capo della pubblica sicurezza al sottoprefetto di Rocca San Casciano, don Pietro veniva definito “capace di ogni delitto, spregiatore delle cose più sacre, dedito soltanto allo sfogo delle più brutali passioni”. Nel rapporto si aggiungeva che il sacerdote aveva creato scompiglio in alcune famiglie “coltivando illecite tresche con donne specialmente coniugate, i mariti delle quali tacciono sul proprio disonore per tema d’incorrere nella vendetta inesorabile di quell’uomo temutissimo da tutti”. Ma c’è di più: il prete era ritenuto complice dei banditi. Pellegrino Artusi, nella sua autobiografia, descrisse con precisione i rapporti di don Pietro con il brigantaggio. Il celebre gastronomo autore della Scienza in cucina affermò che la banda del Passatore commetteva le sue rapine prevalentemente nella Romagna pontificia e subito dopo, per far perdere le tracce, andava a rifugiarsi col bottino nella Romagna toscana, dove “il prete Valgimigli le dava ricetto”. Secondo la “voce pubblica”, e secondo lo stesso Artusi, don Stiffelone non si sarebbe limitato al fiancheggiamento dei briganti, ma avrebbe anche partecipato ad alcuni dei colpi che essi organizzavano, fra i quali l’invasione di Forlimpopoli del 25 gennaio 1851. Trovare le prove per mettere in galera il parroco di San Valentino fu però impresa difficile. Solo nel 1858, sparsasi la voce che il sacerdote stesse addirittura organizzando una banda di malviventi per invadere Tredozio, il ministro dell’Interno del Granducato ordinò di procedere al suo arresto. Non essendoci testimoni attendibili che confermassero i capi d’imputazione più gravi, don Pietro fu condannato a soli tre anni di reclusione, che scontò nel carcere delle Murate. Dopo la scarcerazione non ritornò più in Romagna.
Un altro sacerdote colpevole di favoreggiamento dei briganti fu il parroco di Querciolano, don Antonio Tassinari, condannato per questo reato a due anni e otto mesi di carcere e a cinque anni di libertà vigilata.
Farolfi elenca inoltre, con meticolosa precisione, numerosi altri preti della Romagna toscana che furono riconosciuti responsabili di comportamenti boccacceschi: i parroci di Galeata, San Zeno, Castrocaro, San Michele a Casanova (Firenzuola), Fantella (Premilcuore), San Jacopo in Ontaneta (Rocca), Castagnara (Modigliana), Cannetole (Portico). Questi sacerdoti subirono sanzioni penali e provvedimenti di sospensione a divinis.
Se alcune delle piccanti narrazioni delle gesta di questi sacerdoti potranno far sorridere i lettori, tutt’altro effetto avranno le storie delle rapine e dei feroci assassinii compiuti dai briganti. La strage più efferata fu compiuta il 5 aprile 1851 al Casetto di San Carlo, un podere fra Modigliana e Tredozio, dove gli uomini della banda di Lisagna uccisero con armi da fuoco e da taglio Giuseppe Lombardi e tutta la sua famiglia – moglie, figlio, figlia e genero – perché il Lombardi aveva segnalato alle autorità la presenza in zona di uomini della banda. A fronte di gesta efferate come questa, si può ben comprendere quanto grande fosse la preoccupazione degli abitanti per la sicurezza delle persone e delle proprietà, preoccupazione testimoniata dai documenti e dagli appelli indirizzati al governo perché rafforzasse i picchetti di gendarmeria di stanza nei paesi della Romagna toscana, specialmente nei periodi maggiormente a rischio, quelli delle fiere di bestiame, quando circolavano consistenti somme di denaro. Non mancarono le proposte, avanzate per lo più da proprietari terrieri e da funzionari pubblici locali, che il governo armasse a sue spese i contadini residenti per costituire una forza di appoggio temporanea alle gendarmerie.
Una rapina che suscitò scalpore e grande allarme fu quella messa a segno all’alba del 15 agosto 1852 nei pressi del podere Razzolo, “un miglio sopra Bocconi andando verso San Benedetto”. Sette briganti, ciascuno armato di fucile a due canne, pistola e coltello, assaltarono un consistente gruppo di commercianti che tornavano in calesse dal mercato di Dicomano e li derubarono di tutto il denaro che avevano. Compiuta la rapina i banditi si allontanarono lasciando a piedi i commercianti; i loro calessi furono poi ritrovati in cima al monte Busca. In seguito all’aggressione di Razzolo il sottoprefetto avanzò richiesta al governo di Firenze di rafforzare la presenza militare nel circondario. Il governo agì tempestivamente e inviò a Rocca una compagnia del reggimento dei Veliti toscani, un corpo militare con caratteristiche analoghe a quelle dei Carabinieri piemontesi, composta da ben settantacinque uomini.
Farolfi sottolinea che le strategie di contrasto al brigantaggio decise dalle autorità non furono di semplice attuazione, sia perché i terreni impervi consentivano di sottrarsi facilmente alle perlustrazioni e agli appostamenti delle forze dell’ordine, sia perché i due Stati spesso non riuscivano ad agire con programmi comuni e con spirito di collaborazione, come sarebbe stato necessario. Per di più i banditi godevano, sia nel Granducato che nello Stato della Chiesa, di una rete molto ampia di fiancheggiatori lautamente e regolarmente compensati: “I briganti pagavano uno scudo a testa al giorno per vitto e alloggi e retribuivano con denaro e oggetti ogni altra prestazione, sia gli uomini che procuravano munizioni e armi facendo riparare quelle guaste, sia le donne che provvedevano alla cucina, al vestiario e al bucato”. Fra questi personaggi, definiti comunemente “manutengoli”, ce n’erano anche non pochi che fornivano alle bande le informazioni utili per compiere le loro imprese criminali. Insieme alla pressione militare sul territorio fu quindi necessaria, da parte delle autorità toscane, l’attuazione di un’efficace politica premiale degli informatori, dei collaboratori e dei pentiti, politica che consentì di arrestare e condannare molti complici e fiancheggiatori. Ancor più consistenti i premi in denaro per chi forniva elementi utili per catturare i briganti.
Nel 1856 e nel 1857 le azioni di contrasto ai briganti e ai “manutengoli” furono più efficaci. Anche i rapporti fra le amministrazioni dei due stati migliorarono; ne è la prova quel che avvenne nel gennaio del 1857 a Santa Sofia, quando le guardie di quel paese, avendo appreso della presenza in un podere del Lazzarino e di alcuni suoi accoliti, ed essendo in scarso numero, chiesero e ottennero la collaborazione della gendarmeria pontificia del confinante paese di Mortano. Catturato l’11 gennaio dopo un sanguinoso scontro, il Lazzarino, che era un suddito del Papa e aveva commesso la maggior parte dei reati nel territorio delle Legazioni, fu estradato nello Stato della Chiesa e nel mese di maggio fucilato a Bologna insieme a un complice.
Eliminati il Lazzarino e la sua banda (altri capi banda erano stati uccisi negli anni precedenti), le indagini furono indirizzate verso le persone che avevano supportato i briganti e ben “quarantacinque individui” del Circondario di Rocca furono arrestati. A quel punto il grosso delle truppe che era stato impegnato nella lotta al brigantaggio poté tornare a Firenze.
E’ stato osservato in altre recensioni che il libro sarebbe potuto essere “più snello”. L’osservazione è condivisibile in quanto la ricerca approfondisce anche particolari di scarsa rilevanza. Va tuttavia riconosciuto a questo volume il merito indiscutibile di avere dato risalto a una notevole mole di documenti inediti importantissimi per futuri studi sul brigantaggio, sui rapporti fra gli Stati preunitari e sulla mentalità popolare alla vigilia dell’unità d’Italia. (dal supplemento al n. 87 di “Libro Aperto”, Annali Romagna 2017; si ringrazia il direttore Antonio Patuelli per la gentile concessione)
Pier Luigi Farolfi, Facinorosi pontifici: storie di briganti fra Legazioni e Granducato di Toscana – Libro pubblicato dall’Autore, 2015, pp. 448, € 28
***
M. Flores, Il secolo dei tradimenti: da Mata Hari a Snowden 1914-2014 – il Mulino, Bologna 2017, pp. 328, euro 24,00
Nella Grande Guerra chi non si schiera con il suo paese è un traditore: sono traditori e condannati a morte il patriota italiano ma cittadino austriaco Cesare Battisti così come la ballerina più famosa dell’epoca, Mata Hari, fucilata come spia. Per fascismo, nazismo e comunismo saranno traditori tutti coloro che li combattono: migliaia se non milioni di persone. Nella seconda guerra il tradimento riguarderà soprattutto le spie, mentre nel corso della guerra fredda il clima di paura e sospetto farà diventare traditore chiunque non si dichiari leale al proprio governo. Dai collaborazionisti alle spie atomiche vere o presunte, dai ribelli sudafricani alle lotte intestine dentro i movimenti di liberazione, il concetto di tradimento si trasforma e si amplia fino a inglobare chi combatte per la trasparenza e l’informazione condivisa, come testimoniano in anni recenti i casi Assange e Snowden.
G. Aly, Zavorre: storia dell’Aktion T4: l’«eutanasia» nella Germania nazista 1939-1945 – Einaudi, Torino 2017, pp. 268, euro 30,00
Tra il 1939 e il 1945, circa 200 000 tedeschi furono vittime delle uccisioni per «eutanasia». I numerosi responsabili parlavano eufemisticamente di «sollievo», «interruzione della vita», «morte misericordiosa», «aiuto a morire» o, appunto, di «eutanasia». Costoro agivano in parziale segretezza, ma nel bel mezzo della società. Molti tedeschi erano favorevoli a una morte violenta per i «mangiatori inutili», tanto piú durante la guerra: pochi condannarono con fermezza le uccisioni, i piú tacevano per vergogna, non volevano conoscere troppi particolari. E andò avanti cosí anche dopo il 1945. Solo in casi eccezionali le famiglie si ricordavano delle zie, dei figli piccoli, dei fratelli o dei nonni assassinati. Soltanto oggi, dopo circa settant’anni, l’incantesimo svanisce. Lentamente riaffiorano quei dimenticati che furono costretti a morire perché percepiti come pazzi, molesti o imbarazzanti, perché anormali, pericolosi per la comunità, inabili al lavoro o costantemente bisognosi di cure, perché gravavano di un marchio d’infamia le loro famiglie. Ancora oggi, nelle manifestazioni, nei libri e sui monumenti il piú delle volte i nomi di queste vittime non vengono citati. Eppure sono soprattutto i nomi dei morti, oggi, a dover essere ricordati. I disabili, i deboli di mente e gli storpi che furono abbandonati e costretti a morire non erano affatto non-persone anonime. Questo libro racconta la storia del loro assassinio deliberato, in quella che è nota come la famigerata Aktion T4.
A cura di A. Spiri e G. Quagliariello, Sfida all’Occidente. Il terrorismo islamico e le sue conseguenze. Dall’11 settembre 2001 all’elezione di Donald Trump – Rubbettino, Soveria Mannelli 2017, pp. 238 euro 15,00
Dall’attacco dell’11 settembre 2001 all’offensiva terroristica dei nostri giorni, questo volume ripercorre la trama di una riflessione che sfida il politicamente corretto e l’accusa di fomentare un conflitto di civiltà di cui ancora oggi qualcuno continua a negare l’esistenza. Attraverso una raccolta ragionata degli scritti pubblicati negli ultimi quindici anni dalla Fondazione Magna Carta, e assumendo come centro ideale di gravità il discorso di Benedetto XVI a Ratisbona, il libro contrappone alla banale retorica della difesa degli stili di vita il nesso profondo tra l’attacco all’Occidente e la sua crisi di valori. Dimostrando che non è sufficiente rivendicare la «libertà di aperitivo» ma, per difendere la nostra civiltà, serve il coraggio di arrivare al fondo delle radici cristiane dalle quali essa origina.
Saggi di: Alia K. Nardini, Camillo Ruini, Fiamma Nirenstein, Bernard Lewis, Gaetano Quagliariello, Magdi Allam, Marcello Pera, Joseph Ratzinger, Luigi Compagna, Giovanni Orsina, Angelo Scola, Giancarlo Loquenzi, Gaetano Quagliariello, Lorenzo oranghi, Mauro Marè, Adriana Cerebelli, Eugenia Roccella, Maurizio Molinari, Amel Nona.
G. Marinelli Andreoli, Nel segno dei padri: la storia di Guglielmina e Peter – Marsilio, Venezia 2017, pp. 192, euro 16,50
Guglielmina Roncigli è la figlia di Vittorio, uno dei quaranta civili fucilati nella rappresaglia che la Wehrmacht mise in atto a Gubbio, il 22 giugno 1944, dopo l’uccisione di un ufficiale medico tedesco, Kurt Staudacher, da parte di un gruppo di giovani armati dal gap locale. Le polemiche, nella comunità, sulle responsabilità dell’eccidio – il fatto di sangue più grave in tutta l’Umbria nel periodo dell’occupazione – sono durate decenni. Peter Staudacher è figlio di Kurt. Guglielmina e Peter si incontrano – per caso, ma verrebbe da pensare: per destino – quasi settant’anni dopo. Si riconoscono. Si parlano. Si scrivono, a lungo. Né le colpe, né i meriti dei padri ricadono sui figli: ma Peter e Guglielmina capiscono che l’incontro, per quanto fortuito, ha lasciato in dono una responsabilità: la responsabilità di raccontare, di capire, di comprendere, di perdonare, di riconciliare. La loro storia può sembrare piccola e periferica, ma contiene in sé un messaggio universale. Ovunque un conflitto lascia ferite e macerie; e oggi più che mai c’è bisogno di un esempio come quello di Peter e Guglielmina, che hanno avuto la forza, la tenacia, la capacità di guardare oltre il muro. Le tracce del loro percorso dovrebbero guidarci nelle infinite incertezze del nostro presente.
P. P. Portinaro, L’imperativo di uccidere: genocidio e democidio nella storia – Laterza, Roma-Bari 2017, pp. 306, euro 25,00
L’età dei genocidi è alle nostre spalle? Se facciamo una ricostruzione storica e comparativa dei casi, sforzandoci di comprendere la violenza genocidaria nelle sue molteplici manifestazioni, ci sono molti segnali che inducono a ritenere che anche il XXI secolo sarà un secolo di pulizie etniche e di genocidi. Non si può non rilevare, infatti, che in molte aree del mondo in cui la saturazione demografica raggiunge livelli d’insostenibilità, la sindrome dell’‘uomo superfluo’ si sia aggravata. A ciò si aggiunge l’aumento della violenza democidaria, di cui il terrorismo internazionale è l’esempio più eclatante.
Angela Vettese, Venezia vive: dal presente al futuro e viceversa – il Mulino, Bologna 2017
Un unicum che non smette di emozionare, che suscita sentimenti d’amore, eccitazione, felicità, ma anche disgusto e noia. Nella sua mutevolezza, Venezia, luogo al tempo stesso disertato dai suoi abitanti e invaso dal turismo di massa, è davvero condannata a una morte lenta? In realtà, ciò che sorprende oggi è la sua vitalità, la sua capacità di reinventarsi in modo ingegnoso e sperimentale. Che si parli del restauro del Teatrino di Palazzo Grassi per mano di Tadao Andō, dell’Arsenale, o della Torre Massimiana nell’Isola di Sant’Erasmo, o che si parli della vivacissima rete di istituzioni culturali vecchie e nuove che la animano, Venezia è percorsa tutti i giorni da inediti flussi produttivi e creativi legati al circuito dell’arte e del sapere. È qui, in questa cultura del contemporaneo, la chiave per proiettare la città nel futuro.
